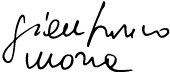Libero sempre
Ricordi famigliari nelle pieghe della grande storia
DI LICIA MORRA
“Yo soy yo, Y mi circumstancia”
(Ortega y Gasset)
Il 27 maggio 2021 si è spento nella sua casa mio padre Gianfranco, all’età di novant’anni. In quei giorni, nelle ore in cui ero accanto a lui, sofferente e prossimo alla fine, e nei giorni dopo la morte, raccogliendo testimonianze, ricordi, saluti e espressioni di riconoscenza, mi sono passati davanti tratti della sua vita, come spezzoni di un film, ricchi di storia e passione. E il dolore per il distacco ha lasciato spazio alla gratitudine per la sua vita e per la sua paternità. E allora, complice anche il mio gusto per la storia che si intreccia con la memoria, è sorto il desiderio di mettere insieme quegli spezzoni, quei frammenti, siano ricordi o racconti, per recuperare una vicenda umana. Ne emerge una storia singolare, certo come tutte, ma il lavoro della memoria esalta questa singolarità: è possibile rintracciare nei diversi tornanti della sua vita l’emergere di una personalità che amici, figli e nipoti riconoscono come “unica”. Frutto delle circostanze? Di un determinato ambiente? Esito di una tempra umana racchiusa nei geni? Comunque si pensi non si può non riconoscere che c’è del mistero, che passa attraverso situazioni familiari, svolte storiche epocali e vicende culturali e politiche: ma il mistero più grande è la libertà di un io che dentro a queste circostanze non si lascia trascinare ma diviene protagonista di un pezzo di realtà acquisendo un volto unico.
1. Storia del piccolo Gianni e di un amore infelice
Bologna, 1930
Nei primi mesi di quell’anno doveva essere freddo, anche se non come l’anno precedente, quando erano caduti metri di neve e il gelo non demordeva. Freddo di certo era il clima politico: spente le ultime opposizioni socialiste e anarchiche, Bologna la “rossa” sembrava ormai aver ceduto sotto una coltre di tacito consenso al regime e, di tanto in tanto, le piazze si riempivano di adunate oceaniche e di soldati in partenza; Bologna la dotta continuava intanto ad essere centro culturale, scientifico e artistico: sono gli anni di Marconi e di Morandi, delle eccellenze in campo ingegneristico e medico. La sua antica università attirava studenti di tutta Italia.
Così anche il giovane Leonardo Morra, di una facoltosa famiglia di proprietari terrieri di Canosa di Puglia, aveva con successo frequentato la facoltà di Medicina ed era ormai prossimo alla laurea. Si trattava solo di far battere la tesi e discuterla per iniziare una brillante carriera di medico. Ebbene proprio la battitura della tesi fu galeotta, e in quel gelido inverno sbocciò l’amore con Gilda, dattilografa. Lei, Ermenegilda Santi, era figlia di un professore di disegno e disegnatore di immagini per libri, Domenico Santi, veneto di origine, e di una donna di origine ebraica, Amelia Melli, proveniente dalla comunità israelitica di Padova. Dal matrimonio nacquero quattro figlie femmine, Ida, Ermenegilda, Clementina e Clara.
Gilda e Leonardo, dunque, a fine novembre vedono la nascita di Gianfranco. Di matrimonio intanto non si parla, anzi la famiglia di lui è del tutto ignara del lieto evento, e il piccolo vive con i nonni materni e le zie. Il padre riconosce il figlio e non vuole allontanarsi da Bologna, per cui coglie la possibilità di esercitare la professione, in attesa dell’Esame di stato, presso la clinica Nigrisoli. Già in questo primo tornante la piccola storia umana si intreccia con la grande storia. Infatti il dott. Bartolo Nigrisoli, romagnolo di origine ma divenuto elemento di spicco della chirurgia bolognese, di giovanili simpatie socialiste, firmatario del Manifesto degli intellettuali antifascisti nel 1931, rifiuta, con pochissimi colleghi, il giuramento al regime fascista. Troppo celebre e amato per essere perseguitato, è però costretto a rinunciare all’insegnamento universitario. La clinica rimane aperta ma con un’attività ridimensionata e il dott. Leonardo Morra si trova senza lavoro e in difficoltà economiche, a complicare un amore difficile, forse per la lontananza fra le famiglie, forse per altri motivi nascosti nelle pieghe dell’animo.
Quello che i ricordi registrano è il resoconto dei fatti: all’età di circa due anni il piccolo Gianfranco, ammalato, deve essere ricoverato in ospedale e la direzione invia la nota spese a Canosa, alla famiglia di lui. Possiamo solo immaginare lo stupore e lo sconcerto della famiglia nell’apprendere di avere un nipote a Bologna: la mamma Incoronata, signora decisa e madre di otto figli, evidentemente dotata di una autorità che non ci aspetteremmo in una società tutto sommato patriarcale, prende il treno e si precipita a Bologna chiedendo al figlio il ritorno a casa, con o senza Gilda. Qui i ricordi sono contrastanti: pare però che Gilda stessa non abbia accettato di trasferirsi al Sud, dicendo così addio al suo unico amore. Leonardo dunque torna a casa, dove trova una fidanzata ben vista dalla famiglia, da cui ha due figli (di uno di questi, Giovanni, parleremo in seguito). Gianfranco riceve il cognome dal padre e negli anni anche aiuti economici: la Zia Clara, sorella di Gilda, era incaricata di incontrare un fratello del Morra, in tragitto verso il Veneto, alla stazione di Bologna ove riceveva una busta con il denaro. Così Gianfranco (in famiglia Gianni) cresce con le cure amorevoli di quattro donne e col cognome di un padre sconosciuto.
2. Una cassa di libri, un gatto e una cartolina del prefetto
Bologna, anni ’30
Dovevano essere molte le difficoltà in quella Bologna degli anni Trenta per quelle sorelle con madre ebrea, con un figlio nato fuori dal matrimonio, e probabilmente il lavoro di illustratore del padre non era sufficiente a condurre una vita agiata. Zia Clara (a lei, la più giovane delle sorelle, morta nel 2017 all’età di 96 anni, dobbiamo buona parte dei racconti) narra di anni difficili ma anche gioiosi: dopo avere frequentato la scuola primaria, in cui aveva come professore “un pittore che disegnava sempre bottiglie” (era Morandi!) aveva abbandonato gli studi e svolgeva piccoli lavori di assistenza (iniezioni a domicilio) e stireria. Nel 1939 vediamo il gruppo famigliare in gita al fiume, in posa per una cartolina ricordo da inviare a Tina, nel frattempo sposata a Milano.
Per quanto riguarda gli anni della scuola elementare ci resta un singolare commento riportato sulla pagella, a testimonianza di un’epoca in cui i maestri davano pratica di scrittura poetica anche nella stesura dei giudizio. “Mobile come uno scoiattolo, flessibile come un giunco, tale è il Morra”: resta aperta la domanda se queste caratteristiche riguardassero il corpo o la mente.

Gianfranco con la sua classe
La frequenza delle scuole medie coincide con l’ingresso dell’Italia nella seconda guerra mondiale. Qui intervengono anche i racconti di Gianfranco: “Durante la guerra ho frequentato le scuole medie S. Domenico. Ricordo con simpatia gli insegnanti, tutti inseriti, per necessità, nelle liturgie del regime, ma privi di fanatismo ideologico. Non ho mai sentito lezioni di propaganda, anche se c’era spesso il richiamo alla solidarietà nazionale e al sacrificio dei soldati per l’Italia. Nessun antiebraismo. Solo il sabato “fascista” si andava a scuola in divisa, i docenti con la camicia nera e gli scolari vestiti da Balilla”. Gianfranco, come raccontava sempre zia Clara, aveva solo un paio di scarpe e doveva stare a casa quando queste necessitavano di riparazioni.
Nel frattempo la situazione famigliare diventa ancora più difficile: il padre, il cui ricordo si era sicuramente perso per Gianfranco, è nominato dalla Croce Rossa medico dei rastrellati italiani in Germania e viene inviato a Magdeburgo, dove trascorre gli anni della guerra, poi fatto prigioniero dai russi e trasferito a Minsk, ove viene impiegato per curare i feriti di guerra. Il ritorno in patria è solo nel 1946. In tutto questo era venuto meno quell’aiuto economico che arrivava al figlio. Le zie e la nonna (ebree a tutti gli effetti per discendenza materna) dopo le leggi razziali avevano perso il lavoro. Per il resto i ricordi delle conseguenze delle leggi razziali sono piuttosto deboli. Il ragazzino Gianfranco non ricorda conseguenze immediate. Così racconta: “Della soluzione finale di Hitler pochi bolognesi erano a conoscenza, scarse notizie giungevano da “Radio Londra” ascoltata clandestinamente. Anche mia nonna, di razza ebraica, visse a Bologna negli Anni della guerra senza mai essere cercata”.
 Verso la fine della vita della zia Clara è emersa dal fondo di un cassetto una “cartolina di mobilitazione” in cui l’ebrea Santi Clara viene pre-avvisata di una possibile convocazione al Centro di raccolta. Di cosa si tratta? Perché poi non è successo nulla?
Verso la fine della vita della zia Clara è emersa dal fondo di un cassetto una “cartolina di mobilitazione” in cui l’ebrea Santi Clara viene pre-avvisata di una possibile convocazione al Centro di raccolta. Di cosa si tratta? Perché poi non è successo nulla?
La memoria inossidabile della zia Clara su questo punto non forniva indicazioni, come se un meccanismo di censura fosse sceso in quegli anni difficili. Tessere per il cibo, mancanza di lavoro, ricordi di vari fidanzati e vicini di casa affollavano i suoi racconti, ma nulla su una possibile deportazione.
In effetti (ho potuto verificare con una veloce ricerca) non si era trattato di una mobilitazione per la deportazione. Infatti la cartolina è del luglio ’43 e la deportazione degli ebrei bolognesi è dell’autunno successivo. Qui si tratta di un progetto di precettazione al lavoro portato avanti dal regime in accordo col Consiglio Provinciale delle Corporazioni in conseguenza delle Leggi razziali: da quello che risulta il progetto si arenò presto per varie ragioni.1La vicenda è ricostruita nel volume “Ebrei e fascismo a Bologna” di Nazario Sauro Onofri (Grafica Lavino, Bologna 1989), pag. 197 (la Precettazione per il lavoro) Certo la convocazione alla questura avrebbe comportato l’inserimento negli elenchi che poi vennero utilizzati per la deportazione. Voci famigliari ci dicono anche che in quei tempi Clara (che non si sposò ma raccontava spesso di numerosi pretendenti) aveva uno spasimante in questura che aveva avvertito di non presentarsi alla convocazione. Bastava questo per sfuggire alla deportazione? Amelia non aveva contatti con la comunità (pur rimanendo di fede ebraica, come documenta la sua sepoltura nel campo degli israeliti in Certosa): il loro nome non risulta negli elenchi della comunità, il padre e i figli erano battezzati e tutto questo può aver contribuito ad evitare persecuzioni. Si possono fare molte congetture ma l’unica certezza è che la famiglia, per parte di madre ebrea, ormai trapiantata a Bologna, scampò alle tragedie della guerra.
Il piccolo Gianfranco doveva suscitare simpatie e non gli mancarono gli aiuti, in una società che di fronte alle difficoltà sa essere solidale. Nello stabile di Via Marsili 17 si era creata una sorta di grande famiglia (oggi si chiamerebbero social-condomini). L’edificio, di proprietà di un notaio, ospitava numerose famiglia, fra cui la famiglia Verondini, proprietaria di un negozio sotto il Pavaglione, che aiutò Gianfranco anche in seguito a proseguire gli studi. Il prof. Verondini, docente emerito di Fisica all’Università di Bologna e di dieci anni più giovane, così ricorda l’amico più grande. “Durante la guerra tutti i condomini avevano allestito la cantina a rifugio. Consapevoli di dovervi passare molte ore era stata predisposta una sala confortevole e ben illuminata, ove le donne si facevano compagnia e gli uomini giocavano a Tressette. Quando al tavolo di gioco mancava il quarto anche il quattordicenne Gianni veniva chiamato al tavolo, apprezzato per la sua arguzia e il suo carattere socievole. Particolarmente apprezzata era la sua capacità di fare le imitazioni”. L’amicizia proseguì negli anni successivi e il professore ricorda che Gianni gli dava “lezioni private” di italiano e che fu proprio Gianfranco a comunicargli la passione per la musica classica.
 Il 1946 non segna un anno di sollievo perché ben presto si ammala e muore il padre Domenico. Restano solo Amelia e le figlie col piccolo Gianfranco. Circondato da tante donne doveva sentirsi oggetto di un amore pieno di cure ma anche un po’ pesante per un adolescente vivace e intelligente, e già dagli anni della guerra si era scatenata la sua passione per la lettura. Gianfranco infatti aveva ideato un singolare business: portava al libraio Veronesi, vicino a Piazza Maggiore, afflitto da topi che sgranocchiavano le pagine dei libri, un gattone affamato che lo liberava delle fastidiose presenze. E il libraio pagava “in natura” prestando libri. Una volta il ragazzino sembrava scomparso durante un bombardamento finché non viene scovato dentro una cassa di libri, dove aveva trovato rifugio e dove era completamente immerso in letture. Ma ormai, negli anni di quel difficile dopoguerra, Gianfranco frequenta il Liceo Galvani.
Il 1946 non segna un anno di sollievo perché ben presto si ammala e muore il padre Domenico. Restano solo Amelia e le figlie col piccolo Gianfranco. Circondato da tante donne doveva sentirsi oggetto di un amore pieno di cure ma anche un po’ pesante per un adolescente vivace e intelligente, e già dagli anni della guerra si era scatenata la sua passione per la lettura. Gianfranco infatti aveva ideato un singolare business: portava al libraio Veronesi, vicino a Piazza Maggiore, afflitto da topi che sgranocchiavano le pagine dei libri, un gattone affamato che lo liberava delle fastidiose presenze. E il libraio pagava “in natura” prestando libri. Una volta il ragazzino sembrava scomparso durante un bombardamento finché non viene scovato dentro una cassa di libri, dove aveva trovato rifugio e dove era completamente immerso in letture. Ma ormai, negli anni di quel difficile dopoguerra, Gianfranco frequenta il Liceo Galvani.
3. Un anarchico al Galvani
Bologna, 1944
Negli archivi del Galvani è riportata la carriera scolastica, non proprio brillante; profitto scarso e condotta un po’ irriverente e un po’ da bullo (con scherzi spiacevoli nei confronti di compagni). La quarta ginnasio fu nell’anno scolastico 1944-45. La linea gotica alle porte di Bologna, i combattimenti e le stragi, poi la Liberazione sono il contesto di questo anno difficile. La frequenza fu frammentaria, anche perché l’edificio del Galvani era una succursale dell’Ospedale Pizzardi per disposizione dell’autorità militare e solo nel tardo autunno vengono resi disponibili alcuni locali in piazza Calderini, dove gli studenti sono convocati circa ogni due settimane, ma non possono essere segnati assenti e/o puniti per non avere svolto i compiti, visto che molte famiglie erano sfollate. Con la fine della guerra, la situazione si normalizza e le lezioni vengono prolungate probabilmente sino a metà luglio per permettere di terminare i programmi. In ogni caso Gianfranco è rimandato in greco e latino, addirittura con 1 in greco… Al Galvani il personale docente e il Preside sono gli stessi del Ventennio, molti di provata fede fascista. Il giovane Gianfranco intanto, anarchico per temperamento e filosoficamente attirato dalla figura di Galvano Della Volpe, che lì aveva insegnato negli anni precedenti, stenta ad adattarsi alla disciplina ferrea, forse anche per intemperanze dovute in parte alla sua storia personale, in parte al frangente storico. In prima liceo registriamo un episodio di “irriverenza” nei confronti del professore di lettere e di scorrettezza nei confronti di un compagno, tanto che per insufficienza in condotta (nel primo trimestre addirittura un cinque) fu rimandato a settembre in tutte le materie. Superato brillantemente l’esame frequenta ancora la seconda liceo al Galvani, poi, dopo essere stato nuovamente rimandato, decide di cambiare scuola, passando al Liceo Minghetti, da cui esce brillantemente decidendo di iscriversi alla facoltà di filosofia. Sono anni in cui ha abbandonato la fede cattolica e si sente vicino a filosofie libertarie e anarchiche.
4. L’università e i grandi amori
Bologna, 1949
Il 1949 segna l’inizio degli studi di filosofia: “Il primo amore, quello che non si scorda mai, scrive molti anni dopo, fu la filosofia” La facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna era un centro vivace di dibattito filosofico, segnata da grandi maestri quali Giuseppe Saitta, Felice Battaglia e Teodorico Moretti-Costanzi, ognuno dei quali ha inciso profondamente nella sua formazione filosofica. Studioso dello storicismo inizia, ben presto, a cogliere i limiti della posizione immanentistica e gradualmente ad aprirsi alla dimensione del sacro. “Fu proprio Teodorico Moretti-Costanzi che mi fece fare l’ultimo passo: il passaggio da una filosofia spiritualistica ad un “cristianesimo come filosofia”. La sua tesi di laurea mostra come il percorso di ricerca sia iniziato e non concluso: “Sono riuscito a scrivere qualcosa di importante? Questa domanda dovrà restare senza risposta perché bisognerebbe, prima, poter distinguere la verità. Quello che ho scritto, comunque, è tutto mio, perché esprime i miei dubbi e le mie certezze”. Sono dunque anni intensi in cui già escono le prime pubblicazioni presso piccole case editrici o all’interno di riviste, già mostrando la varietà dei suoi interessi. E ben presto fa capolino anche il secondo amore, la sociologia. Così si delinea la caratteristica della sua opera, che ha fatto dire di lui “considerato troppo sociologo dai filosofi e troppo filosofo dai sociologi”(Veneziani). Dirà più tardi “non ho amato la seconda moglie meno della prima. Nel terremoto universitario degli Anni Sessanta, sono stato il primo docente di Sociologia nella Facoltà di Lettere e Filosofia e il primo docente di Sociologia della conoscenza nella Facoltà di Scienze politiche”.
Ma negli stessi anni dell’Università trova, sono le sue parole, “allora studentessa, la persona senza la quale non sarei stato capace di percorrere tanto cammino”. Maria Luisa Giardini, figlia del farmacista di Meldola, un paese vicino a Forlì, innamorata delle culture greca e latina si iscrive alla facoltà di Lettere e filosofia. Nei suoi racconti si capiva che Bologna le dovette sembrare grande e fredda, anzi freddissima in quell’inverno del dopoguerra, dove le ragazze, seguendo il dress code del tempo, portavano leggere calze e tacchi a spillo. Ma soprattutto si sentiva disorientata e già arrivare in Università da Via Galliera era un problema, tant’è che per non sbagliare passava da Piazza Maggiore (!). Un problema poi trovare i libri in biblioteca, poco avvezza com’era a schedari e bibliografie. Per fortuna lì, nella biblioteca di Lettere, in via Zamboni, trova Gianfranco, che in mezzo ai libri era di casa, pronto ad aiutarla. I due studenti si frequentano, fra lunghe passeggiate sotto i portici e cene da Lamma all’ombra delle due torri. La laurea è del ’53 per lui e del ’54 per lei. Nel 1956 il matrimonio a Meldola.
Gianfranco in questi anni mantiene il rapporto con l’Università come assistente e già pubblica, ma si sa, non bastava per vivere, quindi tutti e due partecipano al concorso per l’insegnamento nelle scuole superiori. Conseguenza dell’incontro con Isa è il trasferimento a Forlì: Gianfranco qui si sente a casa, forse per empatia con quella vena romagnola un po’ anarchica che non l’ha mai abbandonato, tanto che spesso ripeteva “noi romagnoli”… Nel 1957 sono nata io e nel 1961 mia sorella. In tutti e due i casi, ci raccontano, mio padre dormiva.
 Certo la scelta dei nomi non lo vide assente. C’era allora l’abitudine, che mi risulta oggi in disuso, di assegnare tre nomi al neonato, spesso per ricordare i nonni e i nomi tradizionali della famiglia. Ma Gianfranco colse l’occasione per esprimere le proprie propensioni culturali. Chi meglio di Ipazia, la grande filosofa e scienziata del mondo antico, uccisa da cristiani fanatici e definita la prima martire della libertà di pensiero, nemica dell’oscurantismo cattolico? Sappiamo che però ci fu una trattativa e mia madre preferì anteporre come primo un nome tutto sommato popolare, Licia. Ai due nomi si è aggiunta, e non poteva mancare Sofia, la sapienza stessa. E fu probabilmente anche mia madre che lo convinse a farmi battezzare, visto il periodo caratterizzato da un forte anticlericalismo. Quando nacque mia sorella prevalsero invece i gusti classici della mamma e, dopo Elena, sono seguiti Ecuba ed Elettra. Per fortuna, all’anagrafe dopo il primo nome seguì la virgola e noi non siamo state costrette a portare tre nomi decisamente impegnativi…
Certo la scelta dei nomi non lo vide assente. C’era allora l’abitudine, che mi risulta oggi in disuso, di assegnare tre nomi al neonato, spesso per ricordare i nonni e i nomi tradizionali della famiglia. Ma Gianfranco colse l’occasione per esprimere le proprie propensioni culturali. Chi meglio di Ipazia, la grande filosofa e scienziata del mondo antico, uccisa da cristiani fanatici e definita la prima martire della libertà di pensiero, nemica dell’oscurantismo cattolico? Sappiamo che però ci fu una trattativa e mia madre preferì anteporre come primo un nome tutto sommato popolare, Licia. Ai due nomi si è aggiunta, e non poteva mancare Sofia, la sapienza stessa. E fu probabilmente anche mia madre che lo convinse a farmi battezzare, visto il periodo caratterizzato da un forte anticlericalismo. Quando nacque mia sorella prevalsero invece i gusti classici della mamma e, dopo Elena, sono seguiti Ecuba ed Elettra. Per fortuna, all’anagrafe dopo il primo nome seguì la virgola e noi non siamo state costrette a portare tre nomi decisamente impegnativi…
5. Ricordi di infanzia: l’odore della colla e le corna all’autogrill
Forlì, anni ’60
Osserva Sant’Agostino che la memoria è come un vasto palazzo in cui, misteriosamente, si affollano e si intrecciano ricordi che coinvolgono sensi diversi. Uno dei più vividi è l’odore di colla e della carta stampata. Nel 1963 infatti mio padre aveva fondato una rivista, Ethica, che diresse fino al 1973, anno della chiusura. Ebbene in casa (per risparmiare) avvenivano scrittura, impaginazione, rilegatura e spedizione, precisamente nel salotto di casa, dotato di terribili armadi “svedesi”, acquistato a poco prezzo. Davanti ai miei occhi di bambina sfilavano oggetti affascinanti quali pile di carta, cucitrici, cordelle, buste, etichette ecc.. Non fu un business, come del resto aveva previsto nel primo editoriale, intitolato “L’insuccesso di Ethica”, in cui indica le finalità “inattuali e anacronistiche”. Eppure anche oggi, scorrendo i titoli, si comprende la capacità di cogliere lucidamente alcune grandi questioni che nel tempo hanno mantenuto la loro significanza. Nella palestra di “Ethica” nacquero temi, contatti, amicizie che furono la base del suo percorso filosofico ed accademico successivo. Scorrendo gli indici si nota che intanto la posizione religiosa di mio padre si era modificata ed era sempre più forte l’adesione al cattolicesimo.
Il secondo ricordo riguarda i frequenti viaggi in auto, una Seicento con annesso portapacchi in cui, misteriosamente stavamo in quattro o cinque. Mio padre amava molto viaggiare, sempre in modo spartano e avventuroso: nessuna prenotazione, zaino e panini, sveglia ad ore antelucane. Molte volte con la famiglia, altre, quando la mamma, stremata, non riusciva a tenere il passo, da solo. Erano gli anni Sessanta e l’Italia, in pieno boom economico, aveva inaugurato la rete autostradale: ebbene, passando in automobile era solito esibire, subito rimproverato da mia madre, una gesto scaramantico in direzione dei nuovissimi autogrill. Così fin da bambina ho appreso una diffidenza verso quella “società dei consumi”, che diventerà uno dei capisaldi della sua analisi sociologica, ma soprattutto il gusto per la libertà e la “critica”, il rifiuto di ogni omologazione e il continuo bisogno di conoscere ed esplorare strade nuove, senza rimanere dentro a schemi preconfezionati. E nella vita quotidiana e familiare trovava sempre il modo di esprimere questa sua originalità: dai papillon alle mantelle da “Passator cortese”, dalla passione per il bric-a- brac e le cose antiche agli acquisti dei vestiti usati, in una autentica quanto anticipatrice adesione all’economia circolare. E a noi figli, appartenenti alla generazione dei baby boomers e del consumismo, sembrava stravagante quando ci imponeva, per Natale, di non gettare i nastri e le carte da regalo usate perché potevano essere utilizzate l’anno seguente. Neppure ai “ruoli” stereotipati uomo/donna cedeva: penso di non aver mai visto mia mamma lavare i piatti perché lo faceva lui! Per non dire della sua passione per la cucina..
E non si limitava a cercare cose vecchie nei mercatini ma spesso raccoglieva bicchierini vecchi abbandonati vicino a bidoni, e bottiglie dalla forma strana. Tanto che una volta, a Venezia, il tentativo di raccogliere una di queste gli costò una caduta nel canale, davanti ai nostri occhi un po’ atterriti. Per fortuna sapeva nuotare…
Padre e marito affettuoso, anche se talora un po’ pungente e spinoso, era dedito a un lavoro indefesso, conciliava l’insegnamento della filosofia nelle scuole superiori, gli incarichi in università e gli studi (il tutto reso possibile dalla abitudine, mantenuta per tutta al vita, di svegliarsi prestissimo, quasi come un monaco del lavoro culturale), spesso in viaggio per partecipare a convegni o per dare spazio alla sua inappagabile curiosità.
I suoi studenti ricordano chiarezza, lucidità e sintesi. Memorabili sono stati gli anni di Forlimpopoli, dove insegnò a una schiera di ragazze dell’istituto magistrale, rendendo digeribili i voli di pensiero dei grandi della filosofia. Mi è capitato di incontrare qualcuna di queste ex-studentesse che ammettevano di non capire molto di filosofia ma di sentirsi comunque affascinate. Nella stessa scuola, in seguito a concorso, divenne poi Preside nel 1968. Qui, come si dice, “ha fatto il Sessantotto”, ma i collegi docenti si svolgevano sempre rigorosamente a tavola, e con un bicchiere di albana di Romagna si smorzava ogni tensione di contestazione. È del 1971 il passaggio definitivo all’Università, prima a Lecce, poi a Macerata e infine a Bologna.
6. Zia Giorgia e il fratello ritrovato (e i fili si riannodano)
Padova, 1973
Negli anni Settanta il prof. Morra, oltre all’attività accademica veniva spesso chiamato a tenere conferenze in varie parti d’Italia. Con l’orario dei treni sempre aggiornato appeso nel suo studio, spesso partiva, chiamato da circoli e istituzioni di varie città italiane. Parlava a platee erudite ma anche alle diverse Università per anziani che andavano sorgendo, ma sapeva anche farsi comprendere dalla platea della Coldiretti o dagli studenti di scuola media superiore. Proprio una Conferenza a Padova fu teatro di un incredibile incontro. Nella città veneta infatti si era stabilito con la famiglia lo zio Saverio, fratello del Leonardo Morra, medico militare. Proprio lui, come abbiamo detto, era incaricato di far avere gli aiuti economici per Gianfranco, passando per la stazione di Bologna, ove incontrava zia Clara, senza che questo comportasse un legame fra zio e nipote. Proprio qui a Padova però era venuto a studiare biologia anche Giovanni, il figlio nato dal secondo matrimonio di Leonardo, che poi si era stabilito in città dove aveva sposato Giorgia, destinata a divenire per noi, tardivamente, la zia Giorgia. Lei, veneta schietta e vivace, aliena ai giri di parole, apprese dalla moglie dello zio Saverio quello che il marito Giovanni ignorava, cioè l’esistenza di un fratello a Bologna. Dopo poco il segreto non fu più tale (si sa che le donne parlano…) e così anche Giovanni venne a saperlo, e, incredulo, cercò conferme presso lo zio. Ma forse tutto sarebbe finito così se non fosse stato per l’iniziativa di Giorgia. Impiegata presso una ditta un giorno venne a sapere dal suo titolare che alla Camera di commercio si teneva un incontro con il prof. Gianfranco Morra. Così in una sera del 1973, Giorgia porta il marito ancora non del tutto convinto a quella conferenza e ascoltandolo Giovanni, di schianto, dice “ha la voce di mio padre”. All’uscita di fronte a Gianfranco si palesa la coppia e Giovanni si presenta: “sono tuo fratello”!
Fu così che Gianfranco ritrovò un fratello e io una zia. Negli anni successivi la frequentazione crebbe, Giorgia e Giovanni si fermavano a Forlì e mio padre, di passaggio verso Bassano del Grappa (dove aveva costruito un legame molto forte con il Comune dei giovani e dove aveva fondato il Premio per la cultura cattolica) si fermava a Padova. Più tardi presero l’abitudine di passare qualche giorno in montagna assieme. Mi ha sempre colpito il riannodarsi di questo filo che sembrava reciso per sempre.
7. Sempre a Padova: la sinagoga e ancora zie
Padova, 1990
 A casa di Giorgia, ottima cuoca a vivace ospite, c’è un tavolino antico di legno, acquistato nel ghetto da due note sorelle antiquarie, Ida e Amelia Melli. Ebbene quando ero bambina alcune volte siamo stati a Padova a trovare queste due anziane signore, figlie di un fratello di Amelia Melli, la mamma di Gilda. Due signore ebree, praticanti, che vivevano nei pressi della sinagoga, nubili, gestendo questo negozio di antichità. Ora sappiamo che gli ebrei di Padova hanno pagato un duro prezzo alla persecuzione durante la seconda guerra mondiale. Secondo le memorie orali della famiglia le sorelle erano riuscite a scampare grazie all’aiuto di un sacerdote che era riuscito a farle fuggire in Svizzera tramite il lago Maggiore, grazie anche alla complicità di una guardia di frontiera. Nei loro ricordi c’era, oltre alla memoria della fuga e del terrore, il ricordo di una porticina stretta attraverso cui erano passate, di notte, per ritrovare la libertà. Non ho potuto verificare i dettagli perché la comunità ebraica non conserva memoria di questo evento; quello che ho appurato è che un frate di S. Antonio, padre Placido Cortese, ha dato la vita per salvare alcuni ebrei di Padova, così come una guardia di frontiera, Domenico Amato, ambedue ricordati fra i “giusti fra le nazioni”. Erano loro? Come mai non c’è traccia? Difficile rispondere. Le due sorelle morirono a distanza di pochissimo tempo fra il 1989 e il 1990, ancora legate alla comunità ebraica e al rabbino. Non avendo lasciato eredi quest’ultimo rintracciò l’unico nipote rimasto, cioè mio padre. Convocato a Padova gli venne offerta la cassetta con gli ori delle signore. Lui decise di farne omaggio alla comunità, tanto che il rabbino assicurò di ricordare il suo nome durante le preghiere ebraiche in sinagoga. Un altro filo riannodato con le sue origini che si esprime in questa misteriosa unità della preghiera.
A casa di Giorgia, ottima cuoca a vivace ospite, c’è un tavolino antico di legno, acquistato nel ghetto da due note sorelle antiquarie, Ida e Amelia Melli. Ebbene quando ero bambina alcune volte siamo stati a Padova a trovare queste due anziane signore, figlie di un fratello di Amelia Melli, la mamma di Gilda. Due signore ebree, praticanti, che vivevano nei pressi della sinagoga, nubili, gestendo questo negozio di antichità. Ora sappiamo che gli ebrei di Padova hanno pagato un duro prezzo alla persecuzione durante la seconda guerra mondiale. Secondo le memorie orali della famiglia le sorelle erano riuscite a scampare grazie all’aiuto di un sacerdote che era riuscito a farle fuggire in Svizzera tramite il lago Maggiore, grazie anche alla complicità di una guardia di frontiera. Nei loro ricordi c’era, oltre alla memoria della fuga e del terrore, il ricordo di una porticina stretta attraverso cui erano passate, di notte, per ritrovare la libertà. Non ho potuto verificare i dettagli perché la comunità ebraica non conserva memoria di questo evento; quello che ho appurato è che un frate di S. Antonio, padre Placido Cortese, ha dato la vita per salvare alcuni ebrei di Padova, così come una guardia di frontiera, Domenico Amato, ambedue ricordati fra i “giusti fra le nazioni”. Erano loro? Come mai non c’è traccia? Difficile rispondere. Le due sorelle morirono a distanza di pochissimo tempo fra il 1989 e il 1990, ancora legate alla comunità ebraica e al rabbino. Non avendo lasciato eredi quest’ultimo rintracciò l’unico nipote rimasto, cioè mio padre. Convocato a Padova gli venne offerta la cassetta con gli ori delle signore. Lui decise di farne omaggio alla comunità, tanto che il rabbino assicurò di ricordare il suo nome durante le preghiere ebraiche in sinagoga. Un altro filo riannodato con le sue origini che si esprime in questa misteriosa unità della preghiera.
8. Vacanze
La vita scorreva fra impegni accademici, libri, articoli e conferenze. Noi bambine spesso eravamo a casa con la mamma e con la “dada” Maria che aiutava in casa. Ma d’estate maggiori erano le occasioni per stare assieme. In luglio il babbo non mancava l’appuntamento con gli Esami di stato. Allora si potevano scegliere sedi lontane, e i miei genitori approfittavano dell’occasione per spostarsi in qualche località di montagna, mio padre presidente e mia madre commissaria di Lettere: ricordo in particolare vacanze al Terminillo o nelle montagne del Piemonte. Partivamo in cinque, con la dada Maria al seguito, su una Seicento e il portapacchi montato sul tetto: come era possibile starci tutti coi bagagli non so, ma i tempi erano diversi e certo non c’erano le station wagon. E in agosto a Viserba, frazione di Rimini dove la famiglia di mia mamma possiede una casetta fin dagli inizi del secolo, fatta costruire da una antenata agli albori del turismo balneare in Italia (1906).
 Mio babbo aveva imparato a nuotare e si fermava talora con noi. Certo era del tutto incompatibile con le caratteristiche del turismo di massa ma anche qui aveva trovato un personalissimo modo di viverlo. Un tavolino in fondo al giardino, libri e macchina da scrivere (non stavano nella Seicento, era necessario un secondo giro), una nuotata alle sette di sera e il gioco era fatto. Qualche volta in spiaggia resisteva così, come lo vediamo nella foto, intento a leggere sugli scogli…
Mio babbo aveva imparato a nuotare e si fermava talora con noi. Certo era del tutto incompatibile con le caratteristiche del turismo di massa ma anche qui aveva trovato un personalissimo modo di viverlo. Un tavolino in fondo al giardino, libri e macchina da scrivere (non stavano nella Seicento, era necessario un secondo giro), una nuotata alle sette di sera e il gioco era fatto. Qualche volta in spiaggia resisteva così, come lo vediamo nella foto, intento a leggere sugli scogli…
Una mattina al risveglio troviamo nello sdraio in giardino un signore, altissimo e dall’aria triste e allampanata, che ci chiedeva ospitalità. Era Mario Bemporad, un vecchio professore piuttosto malandato, noto ai bolognesi che lo vedevano girare per via Rizzoli spesso in cerca di qualcuno che lo invitasse a cena perché letteralmente non aveva da mangiare, per mio babbo un amico. Membro di una famiglia di israeliti ferraresi, aveva subito le ferite delle persecuzioni e viveva un profondo senso di abbandono anche da parte dei suoi cari, tanto che ne era stato duramente provato nella psiche e nel fisico. E così lo ospitavamo, dormiva in giardino e poi ripartiva. Nel mio ricordo di bambina è rimasto come immagine dell’eterno ebreo errante, che vaga alla ricerca di una patria.
Un altro ospite assiduo, alcuni anni dopo, era il prof. Achille Ardigò, noto sociologo e collega della facoltà di scienze politiche. E allora si giocava a scopone scientifico. Già, perché il professore era un esperto e conosceva a menadito le pagine del Chitarrella, famoso manuale, che ci sciorinava analizzando il nostro gioco (sbagliato). Credo di avere capito che la sociologia è il tentativo di fare previsioni, riducendo al minimo il ruolo del caso, come nello scopone scientifico. Ma mio padre preferiva il Marafone: gioco romagnolo in cui fantasia e fortuna hanno un ruolo maggiore.
9. Nihil alienum
Molti altri ricordi si affastellano degli anni seguenti e riguardano la sua incessante attività: incarichi universitari, pubblicazioni, collaborazioni con giornali, direzione del corso di laurea, nascita dell’Università di Forlì, Cattedra Sturzo, Premio internazionale della cultura cattolica, conferenze alle platee più diverse, dai grandi filosofi ai soci della Coldiretti. Tutto questo mentre il mondo cambia velocemente: la speranza dopo il crollo del muro di Berlino di una politica migliore e poi la delusione, Tangentopoli e il crollo del sistema politico, l’avanzata dell’islamismo politico. Guardando le pile di carpette, con un titolo nell’etichetta, in cui meticolosamente archiviava i suoi articoli, interviste, conferenze (tutte meticolosamente preparate) mi chiedo cosa tenesse assieme cose così diverse. Ma in fondo c’è un punto unitario, ed è questa curiosità mai paga per ogni aspetto dell’umanità. Ogni mostra nel più sperduto angolo dell’Italia meritava una visita e uno scritto. Mi sono sempre chiesta perché a un certo punto si sia impegnato in politica, in occasione delle elezioni regionali del 1995, partecipando come consigliere all’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Nessuno più “ impolitico” di lui, con la sua ironia tagliente che spesso lo ha portato a rompere amicizie e relazioni, con la sua incapacità di venire a compromessi. E nessun vantaggio di carriera o economico. Anche qui non mi resta che ricorrere alla sua curiosità, il desiderio di fare nuove esperienze, per conoscere e insegnare.
E ricordo anche le discussioni avute con lui, quando dissentivo dalle sue posizioni, ma soprattutto il dolore di una comunicazione sempre più difficile a causa di una sordità crescente; la sua flessibilità dell’apprendere l’uso del pc e della rete, tanto che le mail erano diventate per lui quasi novantenne il vitale strumento di comunicazione.
Difficilmente riesco a distinguere la figura del padre da quella del maestro. Autorevole e mai autoritario mi ha comunicato l’amore per la verità, la passione per l’uso della ragione e il rifiuto del conformismo, che mi affascinavano da ragazzina e che tanta parte hanno avuto nella scelta di studiare filosofia e dell’insegnamento. Nello stesso tempo sono inseparabili dall’affetto che portava a noi figlie, ai nipoti e alla mamma.
Una volta mi raccontava che Tommaso d’Aquino prima di morire, riferendosi ai suoi libri aveva detto “Sunt mihi palae”, sono pagliuzze di fronte all‘ Eterno; e col realismo che lo caratterizzava sottolineava che tutto ha una fine. Più volte nei giorni della sua dipartita, anche guardando i libri della sua biblioteca o l’articolo lasciato a metà nel momento del ricovero, mi è venuto in mente quest’episodio. Eppure sono certa che di fronte all’Eterno che si è fatto carne nulla andrà perduto, che non andranno perdute le pagliuzze disseminate in questi lunghi anni. Mi piace immaginarlo ora libero di studiare e di soddisfare la sua grande curiosità.